Le poche modifiche intercorse dalla bozza del Testo Unico FER al testo finale hanno creato della confusione, soprattutto sugli stoccaggi, ma anche delle novità positive per revamping e repowering. Lo dice a pv magazine Italia Cristina Martorana, partner di Legance, aggiungendo che rimangono invece i dubbi sulle cave, perché l’utilizzo a fine energetici rientra ormai nelle competenze delle regioni, e sull’agrivoltaico, perché il legislatore ha perso la possibilità di fornire definizioni chiare, forse rimandando ancora una volta alle regioni. “Diciamo che nel caso dell’agivoltaico l’ultima parola la diranno le regioni, che saranno le uniche a poter stabilire quali tipologie di agrivoltaico sponsorizzeranno, se lo vorranno e a quali condizioni (anche soggettive e di potenza). E forse per questo la mancata definizione di agrivoltaico può dirsi voluta”.
pv magazine: Il Testo Unico FER (Tufer) è entrato in vigore a fine anno. Quali le novità principali rispetto alla bozza che circolava a ottobre 2024?
Cristina Martorana: Il testo entrato in vigore il 30 dicembre 2024 non differisce molto dalla bozza che circolava ad ottobre ma laddove ciò accade l’impatto non è di poco conto. Anzi. L’art. 1 comma 1 della bozza si proponeva di definire “i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione e stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dei medesimi impianti”. Il testo approvato non contiene più il riferimento alla parola “stoccaggio”. La qual cosa ha indotto qualcuno a dubitare che quest’ultima tipologia di infrastruttura fosse disciplinata dal Tufer. Perplessità parzialmente, ma non del tutto, fugata da una triplice circostanza. Innanzi tutto, dal fatto che gli impianti di stoccaggio di energia stand alone sono espressamente indicati in ognuno degli Allegati del Tufer che listano le diverse tipologie di impianto soggette ai diversi regimi autorizzativi; in secondo luogo, dal fatto che la normativa che disciplinava gli iter autorizzativi ai quali erano soggette dette infrastrutture è inclusa nell’Allegato D contenente l’elenco delle disposizioni abrogate con l’entrata in vigore del Tufer; infine, dal fatto che l’art. 12 del Tufer sulle Zone di accelerazione prevede espressamente gli stoccaggi tra le infrastrutture che dovranno essere tenute in considerazione in fase di definizione di dette zone. Dalla lettura delle diverse previsioni ricaviamo che le procedure autorizzative degli stoccaggi di energia stand alone sono sostanzialmente sovrapponibili alle precedenti, al netto del cambio di competenza passata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) alle regioni in caso di stoccaggi di potenza fino a 200 MW come già previsto in bozza. Di contro, “è scomparsa” la disciplina relativa agli impianti di stoccaggio integrati con impianti FER, così come la loro equiparazione, in ottica di definizione, alle opere connesse agli impianti FER.
Parlando ancora di differenze, registriamo invece con favore il fatto che sia stata inserita la disciplina relativa agli interventi di revamping e repowering su impianti esistenti sulla falsariga dell’abrogato art. 6 bis del Decreto Romani, a parità di condizioni.
La complessità legata alle cave è stata risolta? A che punto siamo con le cave?
Nell’ambito del Tufer sì, dato che il legislatore adesso parla unicamente di cave “non suscettibili di ulteriore sfruttamento” o semplicemente di cave quando si riferisce alle aree ove – a certe condizioni – possono essere autorizzati stoccaggi stand alone con procedura semplificata. Non direi però che sia definitivamente risolta la complessità legata alle cave dato che è al momento rimasta una diversa definizione delle stesse nell’ambito della norma che disciplina le aree idonee a livello nazionale (art. 20, comma 8, D.Lgs 199/2021) e che, come noto, la disciplina delle aree idonee a livello ragionale è ancora in alto mare per le note vicissitudini. Una volta che il quadro sarà definito e potremo andare ad analizzare come le diverse regioni avranno disciplinato le condizioni per la coesistenza tra cave e impianti FER capiremo se finalmente sarà “sorto il sole”.
La definizione dell’agrivoltaico, l’entrata in vigore e i regimi transitori sembrano ancora non chiari. Sbaglio?
Non sbaglia. Il legislatore ha perso l’occasione (ma forse volutamente) di dare una definizione di agrivoltaico. Quest’ultimo è espressamente previsto sia negli Allegati A e B che identificano gli impianti che possono essere autorizzati rispettivamente in edilizia libera e procedura semplificata, nonché nella norma di coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali (art. 13). Nel prevederlo il legislatore abbina il concetto di agrivoltaico con quello di un impianto che deve consentire “la continuità dell’attività agricola e pastorale” o “ l’effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole”. Non vi è alcun cenno a caratteristiche strutturali che lo stesso deve avere per definirsi agrivoltaico, né a concetti di sopraelevazione e tanto meno di misure minime. Le linee guida ministeriali del 27 giugno 2022 sono ancora in vigore, così come l’art 65, commi 1-quater e 1-quinquies del DL 1/2012, ma non è chiaro come queste si rapportino con il Tufer. Diciamo che nel caso dell’agivoltaico l’ultima parola la diranno le regioni, che saranno le uniche a poter stabilire quali tipologie di agrivoltaico sponsorizzeranno, se lo vorranno e a quali condizioni (anche soggettive e di potenza). E forse per questo la mancata definizione di agrivoltaico può dirsi voluta.
Per quanto riguarda invece il regime transitorio, al di là dell’infelice previsione del comma 3 dell’art 1 del Tufer che disciplina la fase di “possibile” implementazione regionale, ritengo che ci sia un’unica lettura che possa considerarsi in linea con lo spirito e la tecnica legislativa. E cioè quella che fa perno sull’art. 15, alla luce del quale a partire dal 30 dicembre 2024 il Tufer è entrato in vigore, con conseguente abrogazione delle disposizioni normative elencate nell’Allegato D e di tutte quelle, che pur non elencate, risultano incompatibili con il nuovo testo. Il Tufer, pertanto, è immediatamente applicabile al netto dei procedimenti autorizzativi pendenti al momento della sua entrata in vigore che potranno avvalersi del regime previgente a condizione che “la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del decreto”. Il tutto ferma restando la possibilità per il soggetto interessato di richiedere comunque l’applicazione del Tufer. Ne segue che, a mio avviso, ciò che potranno fare le regioni nei 180 giorni concessi sarà unicamente (i) adeguare le normative regionali previgenti alla nuova normativa laddove necessario in quanto ispirate a principi diversi da quelli del Tufer per come disciplinati dall’art. 2; ed (ii) eventualmente ampliare la portata della semplificazione attraverso anche l’innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi che andranno in edilizia libera o procedura abilitativa semplificata, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’art. 13 del Tufer che prevede che detti interventi non siano sottoposti alle valutazioni ambientali ma, potenzialmente, a valutazione d’incidenza.
Per quale motivo la definizione dell’agrivoltaico è importante in questo momento e cosa potrebbe fare il legislatore per chiarire la questione?
È importante per garantire certezza, uniformità e omogeneità di trattamento. Ad oggi abbiamo assistito a situazioni in cui sono stati autorizzati impianti che quasi niente hanno di agrivoltaico se non il nome contenuto nel titolo autorizzativo, ad altre in cui è stato imposto allo sviluppatore di progettare l’impianto implementando tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti per impianti incentivabili con fondi Pnrr anche se non era questa l’intenzione. Il che ha determinato un forte rallentamento degli investimenti in una tecnologia, quella dell’agrivoltaico, che potrebbe invece rappresentare il volano per la valorizzazione o il recupero di aree a destinazione agricola non coltivate in linea con le loro potenzialità o non coltivate affatto, in quanto abbandonate o divenute aride. In questo contesto il legislatore avrebbe potuto dare una direttiva chiara, sottolineando che al di là delle singole caratteristiche, l’elemento fondante e imprescindibile dell’agrivoltaico è che lo stesso garantista la compatibilità, l’integrazione o la continuità con e dell’attività agricola. Non lo ha fatto, come dicevamo, forse volutamente. Si spera lo facciano le regioni con ragionevolezza.
Parlando con gli operatori, comunque mi sembra che i regimi transitori sono tali per cui non sarà facile per gli operatori capire esattamente come gestire dei progetti già in via di sviluppo. Quali sono i progetti più “a rischio”?
Purtroppo non sono (o non dovrebbero essere) i progetti ad essere a rischio. La norma sul transitorio è chiara. Ciò che è a rischio è come l’ente autorizzante, sia esso la regione o l’ente locale, la interpreta. Ci sono regioni, come la Campania, che correttamente ritengono che il Tufer sia direttamente applicabile e si muovono di conseguenza. Altre sono state confuse dal ricordato comma 3 dell’art. 1. Una circolare ministeriale interpretativa aiuterebbe.
Di sicuro lo scossone principale lo hanno avuto i progetti di stoccaggio di energia stand alone che hanno visto passare la competenza autorizzativa dal Mase alle regioni. Ma come sempre la soluzione la dà la professionalità e la buona volontà dei soggetti che devono istruire le pratiche, che non dovrebbero trincerarsi dietro un presunto transitorio per rifiutare una protocollazione, dato che sono gli stessi soggetti che già istruivano progetti di stoccaggio integrati con FER.
Quale il ruolo del Consiglio di Stato in questo contesto?
Il Consiglio di Stato ha correttamente sospeso l’efficacia di una previsione del Decreto Aree Idonee che gridava vendetta. Era, ed è, folle pensare che le regioni possano normare in materia di aree idonee in maniera difforme dalla normativa nazionale che ormai qualche anno sta guidando gli investimenti. Adesso la parola è al Tribunale amministrativo e si spera che confermi il pensiero del Consiglio di Stato. Diversamente non rimarrà che fare appello. L’azione giudiziale intentata da alcuni operatori e supportata dalle associazioni di categoria non è volta a stravolgere, annullare, l’intero decreto, ma a correggerne le storture e riformulare le previsioni che, per come scritte, a causa dell’enorme discrezionalità lasciata alle regioni non garantirebbero omogeneità di trattamento sull’intero territorio nazionale come, di contro, richiede lo stesso Tufer all’art. 2.
Quali potrebbero essere le tempistiche per la revisione del Testo Unico FER?
Difficile dirsi, anche perché dipende da quanto consenso c’è sulle revisioni da fare. Vari sono “i treni” che queste revisioni potrebbero prendere, a partire dal prossimo decreto energia. Di certo mai come adesso il mercato sente l’esigenza di mettere la parola “punto” all’evoluzione normativa, che spesso si è tradotta in un’involuzione. Il problema però è sempre lo stesso; il punto potrà essere messo solo quando avremo un quadro regolatorio chiaro, limitante al massimo lo spazio interpretativo, e richiedente unicamente una fase implementativa nel rispetto dell’art. 117 della Carta Costituzionale.
Altri punti e/o considerazioni rilevanti?
È notizia delle ultime settimane l’imminente pubblicazione di una normativa che dovrebbe risolvere (in tutto o in parte) il problema della saturazione “virtuale” della rete. Entro il 21 maggio 2025 il GSE dovrà pubblicare sul suo sito internet una mappatura del territorio nazionale, individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l’installazione degli impianti FER e gli stoccaggi, quale primo step per la successiva implementazione delle zone di accelerazione da parte delle regioni. Quest’ultime avranno tempo fino al 21 febbraio 2026. Non è chiaro in che rapporto si porranno rispetto alle aree idonee che le stesse regioni a quel punto avranno identificato. I decreti di incentivazione, dal FER X transitorio, al FER X, al FER 2, al FER Z, al Macse, al biometano, all’Energy Release, stanno prendendo forma contribuendo a delineare il nuovo mercato elettrico. Ormai è chiaro e indiscutibile (e mi pare non più discusso) che la transizione energetica passerà per un importante ruolo che ancora avrà nel tempo il gas e le relative infrastrutture energetiche. Si sta affacciando il nucleare. Forse la revisione del Tufer dovrebbe prendersi un po’ più di tempo al fine di ricondurre a sistema tutto questo, in un quadro armonico, nell’ambito di una strategia definita, almeno nel breve periodo.
I presenti contenuti sono tutelati da diritti d’autore e non possono essere riutilizzati. Se desideri collaborare con noi e riutilizzare alcuni dei nostri contenuti, contatta: editors@nullpv-magazine.com.




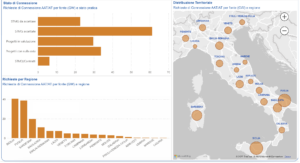
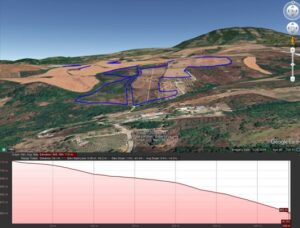

Inviando questo modulo consenti a pv magazine di usare i tuoi dati allo scopo di pubblicare il tuo commento.
I tuoi dati personali saranno comunicati o altrimenti trasmessi a terzi al fine di filtrare gli spam o se ciò è necessario per la manutenzione tecnica del sito. Qualsiasi altro trasferimento a terzi non avrà luogo a meno che non sia giustificato sulla base delle norme di protezione dei dati vigenti o se pv magazine ha l’obbligo legale di effettuarlo.
Hai la possibilità di revocare questo consenso in qualsiasi momento con effetto futuro, nel qual caso i tuoi dati personali saranno cancellati immediatamente. Altrimenti, i tuoi dati saranno cancellati quando pv magazine ha elaborato la tua richiesta o se lo scopo della conservazione dei dati è stato raggiunto.
Ulteriori informazioni sulla privacy dei dati personali sono disponibili nella nostra Politica di protezione dei dati personali.